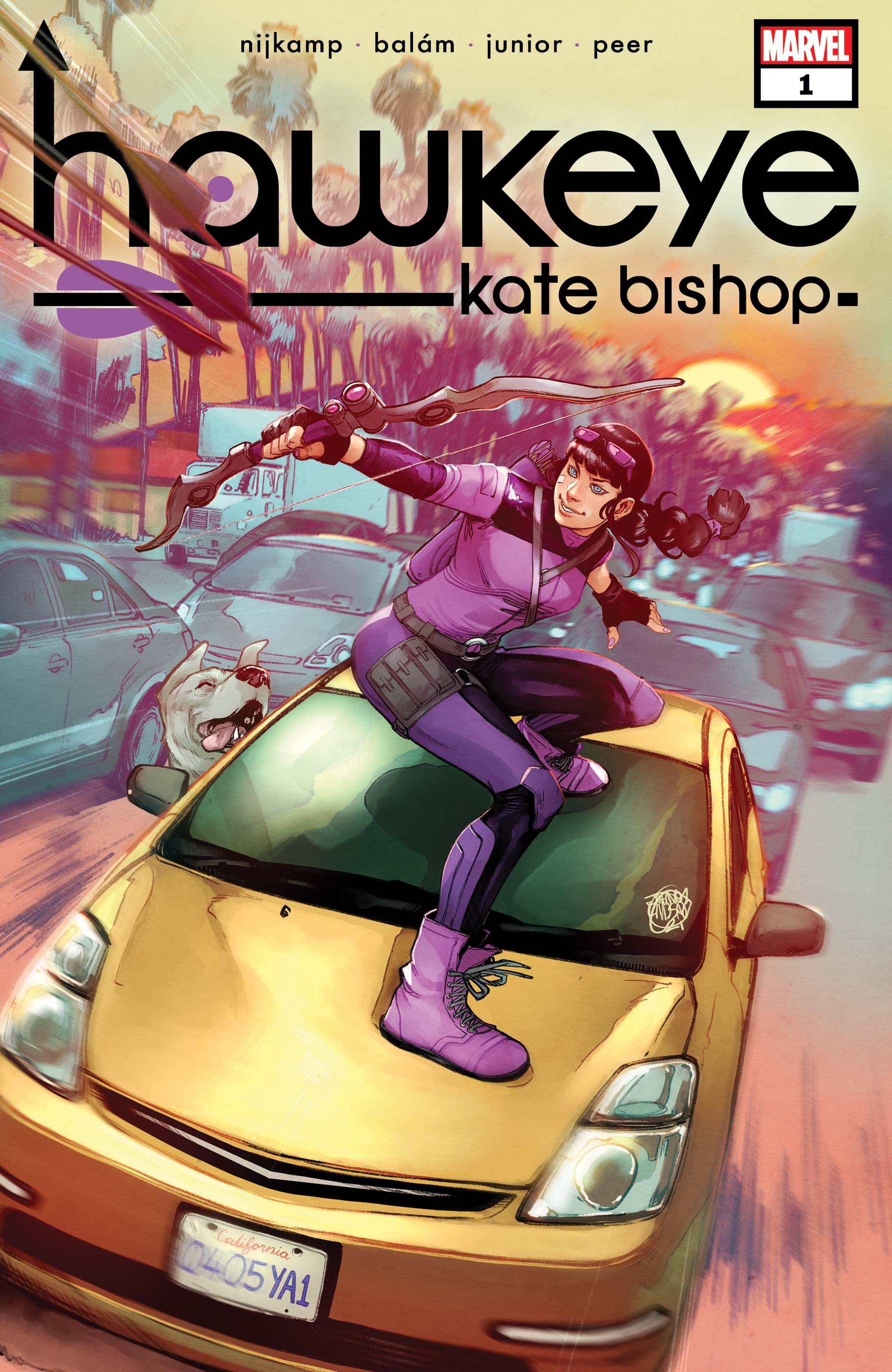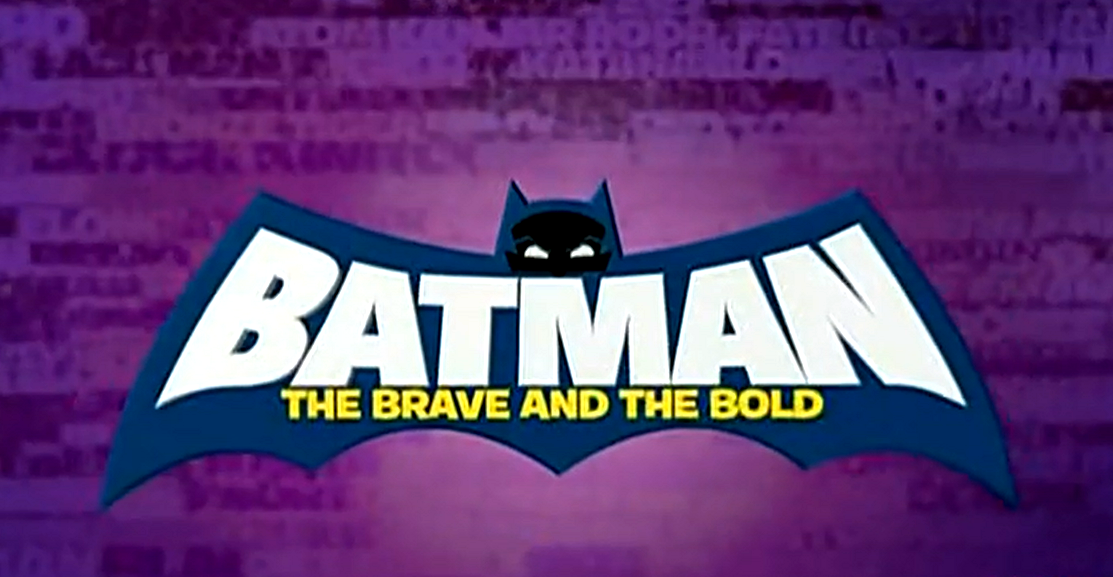
Nel multiverso DC, le versioni e le reinterpretazioni dei suoi
eroi cambiano di continuo. Tuttavia, alcuni principi rimangono
costanti: la lealtà, la missione condivisa
e la visione di giustizia che accomunano la Justice
League sin dalle sue origini.
In Batman: The Brave and the
Bold, la serie animata nota per il suo tono avventuroso e la
celebrazione della Silver Age, si è spesso giocato con l’idea di
team alternativi — tra cui la Justice League International
(JLI) — ma senza mai rompere il legame con la Justice
League originale.
La domanda, dunque, è legittima:
perché Batman, Aquaman e Martian Manhunter non hanno mai
abbandonato la League primordiale per unirsi stabilmente alla JLI?
La risposta non è una sola, ma intreccia motivazioni narrative, tematiche e simboliche, radicate nell’essenza di ciascun personaggio e nella filosofia stessa della serie.
1. La Justice League originale come fondamento dell’ideale eroico
La Justice League — formata da Superman, Batman, Wonder Woman,
Flash, Green Lantern, Aquaman e Martian Manhunter — rappresenta la
colonna vertebrale morale e simbolica dell’universo DC.
In
ogni medium, dalla carta alla televisione, il gruppo è più di
un’alleanza: è il pantheon degli dei moderni, un
riflesso della cooperazione ideale tra potere, intelligenza e
compassione.
In Batman: The Brave and the Bold, questo concetto è
rispettato con devozione.
Pur introducendo team alternativi e
alleanze occasionali (come Outsiders, JLI o Birds of Prey), la serie
evita di smantellare la League classica, perché essa incarna la
stabilità e la continuità dell’eroismo DC.
Batman,
Aquaman e Martian Manhunter non l’abbandonano proprio perché sono
i custodi di quell’ideale fondante.
Sono la spina
dorsale silenziosa della squadra: quando gli altri si disperdono o
cambiano, loro restano.
2. Batman: il stratega, non il disertore
Batman è, per natura, un solitario. Eppure,
nella Justice League, trova qualcosa che perfino Gotham non può
offrirgli: fiducia reciproca.
Nelle versioni più
classiche, Bruce Wayne è un membro che osserva, analizza e
pianifica, spesso in contrasto con le personalità più “divine”
del gruppo come Superman o Wonder Woman.
Nel contesto di The Brave and the Bold, il Batman di
Diedrich Bader è più luminoso, ironico e collaborativo.
Il suo
ruolo non è quello del leader ombroso, ma del collante
tattico tra eroi di ogni tipo.
La sua partecipazione alla
Justice League International, in questo universo, è episodica, non
permanente.
Perché?
Perché Batman, pur apprezzando la varietà
e l’informalità della JLI, riconosce che la missione più
grande — quella della Justice League originale — è
irrinunciabile.
Abbandonarla significherebbe rinunciare
al punto di riferimento morale e operativo che tiene unito l’universo
DC stesso.
In breve: Batman può collaborare con la JLI, ma non
appartiene a loro.
La sua mente strategica è
indispensabile dove si decide il destino della Terra, non dove si
alternano missioni più leggere o politicamente caotiche.
3. Aquaman: l’eroe regale e il legame con la tradizione
Aquaman, nel tono più leggero e ironico di The Brave and the
Bold, è rappresentato come un sovrano impulsivo, teatrale e
irresistibilmente entusiasta.
Ma dietro la facciata comica resta
un re, un guerriero responsabile non solo del mondo
di superficie ma anche dell’oceano e del popolo di Atlantide.
Per questo, Aquaman non lascia mai la Justice League originale:
perché rappresenta la voce del regno di Atlantide nel consesso degli eroi;
perché il suo ruolo nella League non è solo fisico ma politico e simbolico;
e soprattutto, perché la sua lealtà è una virtù regale.
La Justice League International, per quanto affascinante, non
rispecchia la serietà e la grandezza mitica che Aquaman cerca.
Nel
suo cuore, lui è parte di una fratellanza di titani,
non di un club di eroi minori o comici.
Anche nelle sue versioni
più leggere, il sovrano del mare rimane legato all’ordine
originario delle cose.
4. Martian Manhunter: l’anima della Justice League
Se Superman è il simbolo della speranza, Martian
Manhunter (J’onn J’onzz) è l’anima della Justice
League.
È il custode morale, l’empatico, la voce calma in mezzo
al caos.
La sua connessione telepatica e spirituale con i membri
del team lo rende un punto d’equilibrio tra mente e cuore.
Nel mondo di The Brave and the Bold, J’onn è spesso
ritratto come il più razionale e introspettivo, ma anche come il più
legato alla famiglia della League.
Abbandonare la
squadra originale per entrare nella Justice League International
sarebbe, per lui, una forma di tradimento emotivo.
Non
perché disprezzi la JLI, ma perché la Justice League
classica rappresenta la sua seconda casa, quella che gli ha
offerto appartenenza dopo la perdita di Marte e del suo popolo.
In altre parole, Martian Manhunter non combatte solo per
la giustizia, ma per la memoria.
E la memoria, per lui,
si conserva restando.
5. La Justice League International: spirito, non sostituzione
È importante ricordare che, in Batman: The Brave and the
Bold, la Justice League International non nasce
come rivale, ma come ramificazione naturale del
concetto di collaborazione globale tra eroi.
La serie omaggia
l’epoca in cui la JLI, nei fumetti, portava leggerezza, umorismo e
dinamiche politiche nel mondo dei supereroi (la celebre gestione di
Keith Giffen e J.M. DeMatteis negli anni ’80).
Tuttavia, questa versione animata non intende sostituire la League
principale.
Piuttosto, espande il mondo,
mostrando che l’eroismo può assumere molte forme, ma che
l’archetipo originario resta intoccabile.
Batman,
Aquaman e Martian Manhunter sono dunque il ponte tra il mito e la
sperimentazione, tra il classico e il moderno.
6. Simbolismo meta-narrativo: il rispetto delle radici
Infine, da un punto di vista meta-narrativo, The Brave and the
Bold è una lettera d’amore alla storia DC.
Ogni
episodio è costruito per rendere omaggio non solo ai personaggi
principali, ma anche alle loro eredità editoriali.
Far
abbandonare la Justice League originale a tre dei suoi fondatori
avrebbe spezzato quella linea di continuità che la serie voleva
celebrare.
In altre parole, la loro permanenza non è un vincolo di
trama, ma un atto di rispetto.
Batman, Aquaman e Martian
Manhunter restano dove tutto è cominciato, a custodire il simbolo,
mentre nuove generazioni di eroi portano avanti la torcia altrove.
Batman, Aquaman e Martian Manhunter non hanno abbandonato la
Justice League originale perché rappresentano le sue
fondamenta.
Ognuno di loro, con la propria visione, tiene
in vita ciò che la Justice League significa:
Batman la strategia e il sacrificio,
Aquaman la regalità e la lealtà,
Martian Manhunter la compassione e la memoria.
La Justice League International può cambiare, evolversi o
sciogliersi.
Ma la League originale è eterna — e questi tre
eroi sono i suoi guardiani, gli ultimi a partire e i primi a tornare,
ogni volta che la Terra ha bisogno di loro.